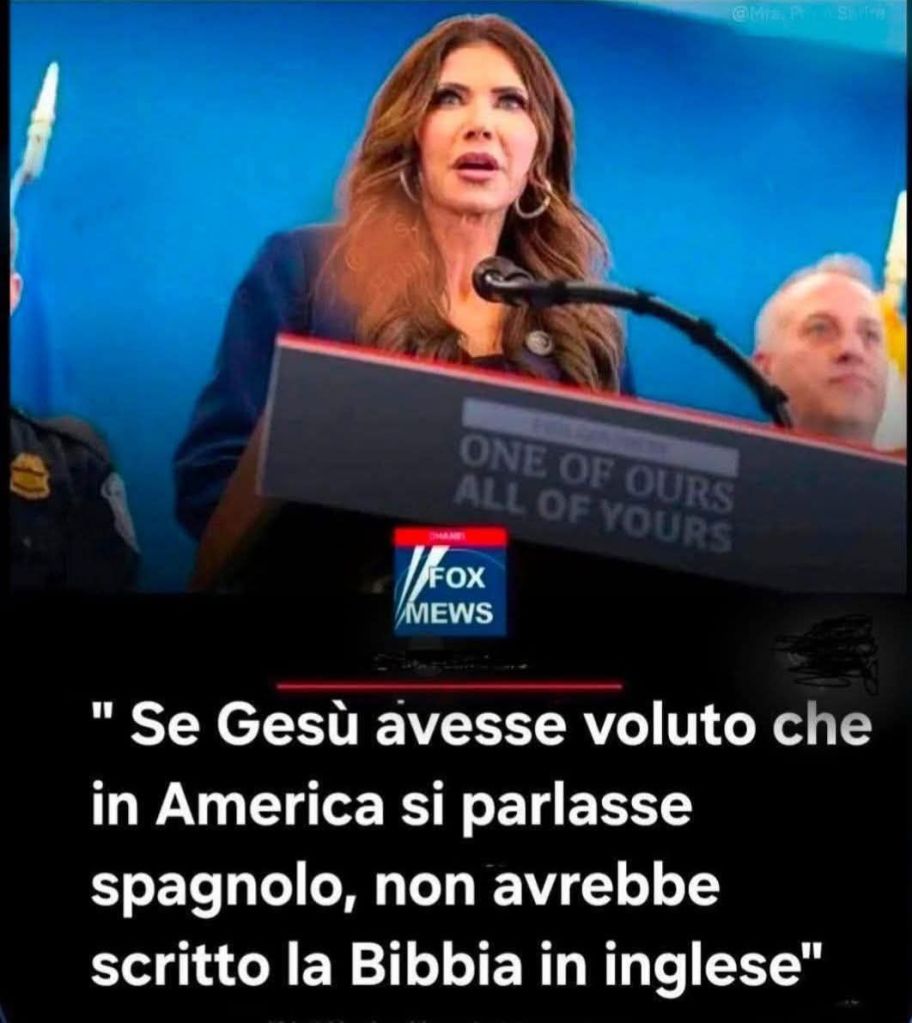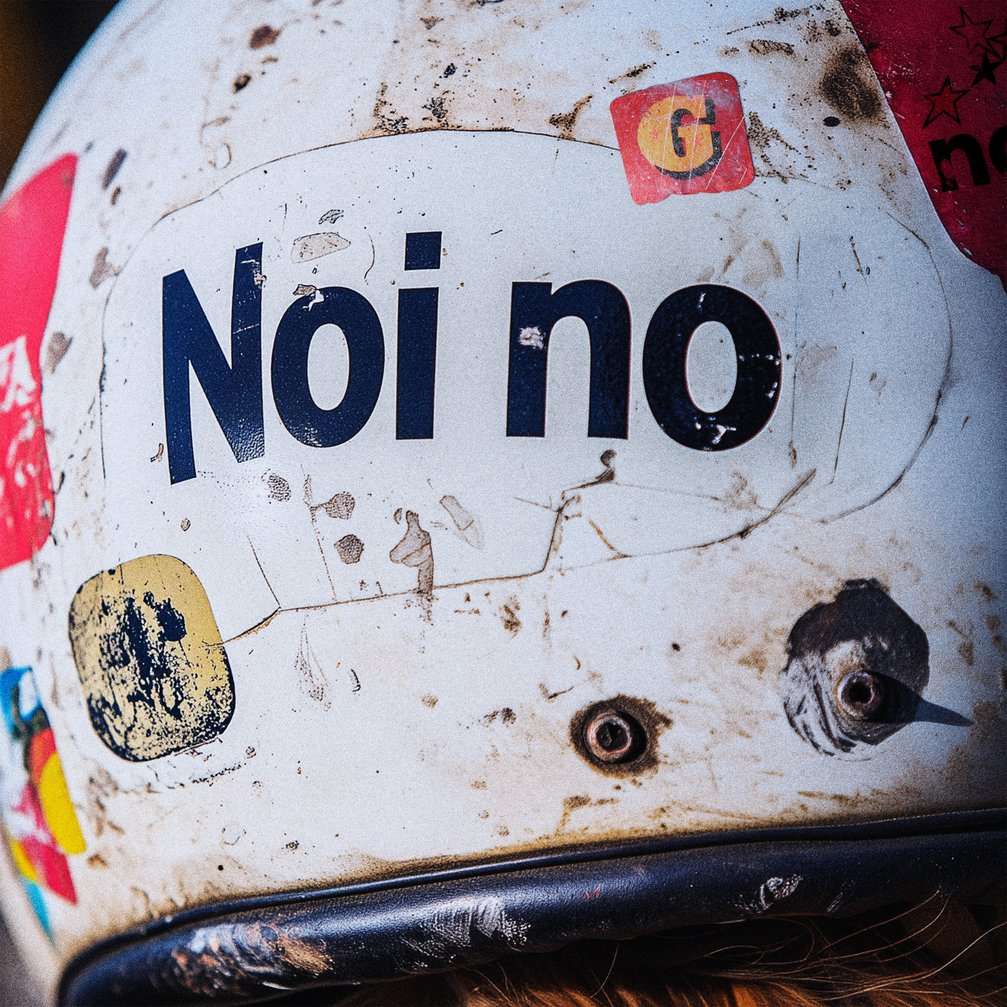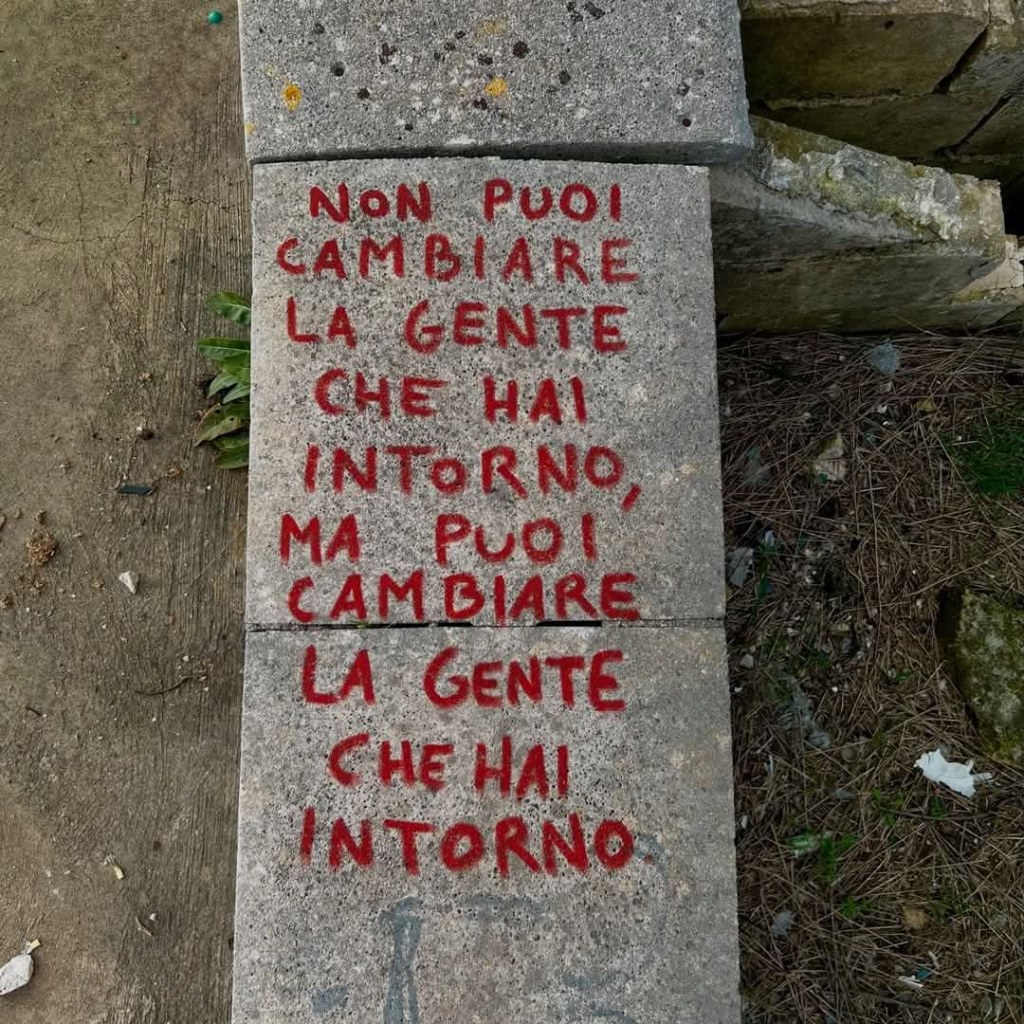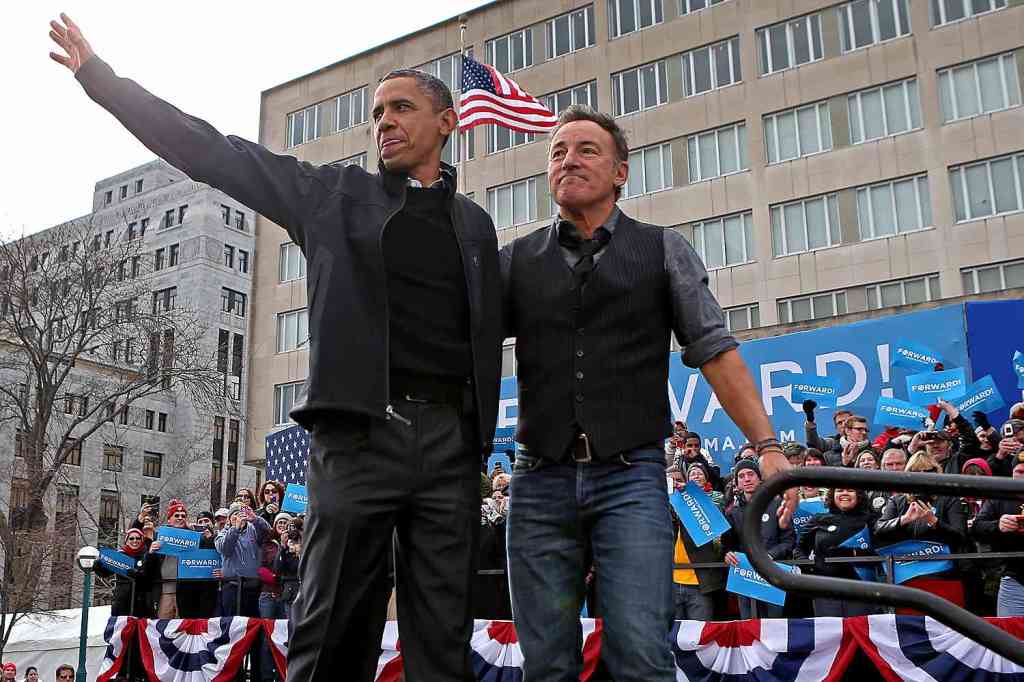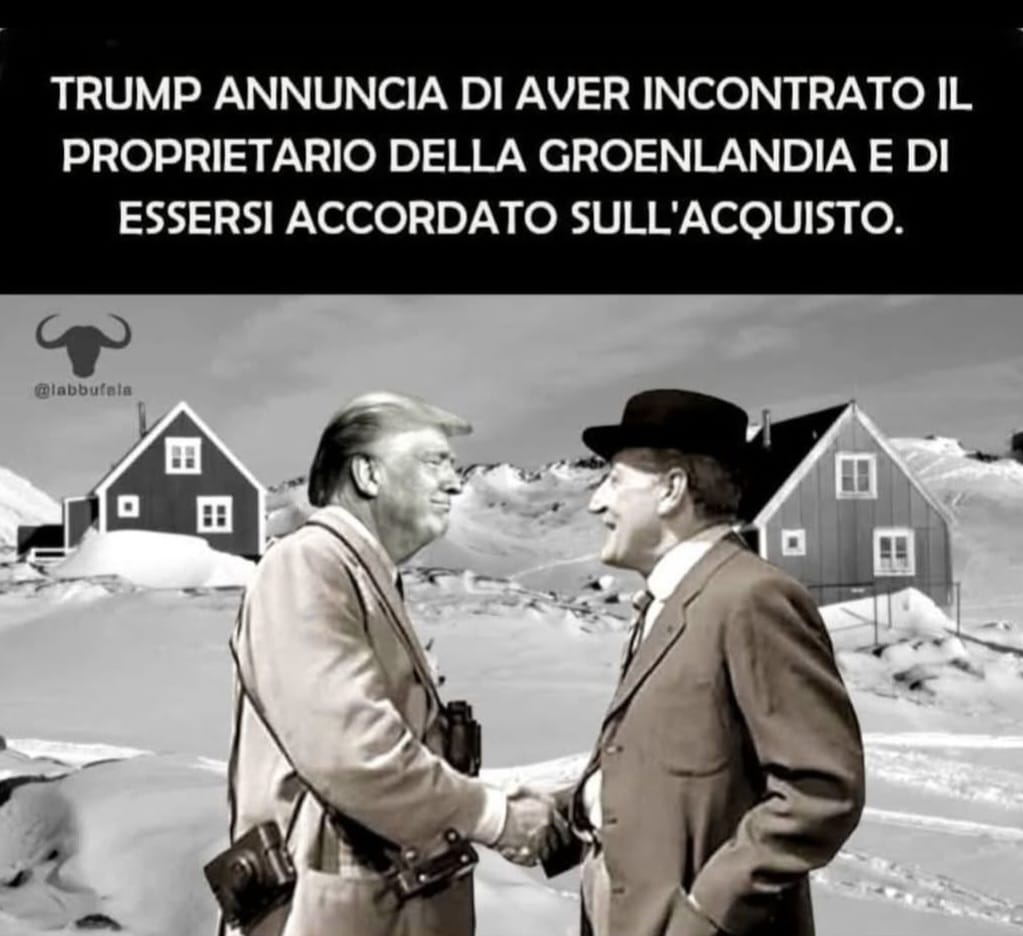Il fetido cortile ricomincia a miagolare, l’umore è quello tipico del sabato invernale, la radio mi pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori…
Come già forse ricorderete, cari viaggiatori ermeneutici, riguardo il festival di San Remo, sono dell’opinione che c’è chi lo guarda e chi mente. Ma al di là della battuta, non importa quanto uno lo segue o non lo segue, da qualche anno a questa parte è diventato sempre di più uno specchio dei nostri tempi. Con le sue polemiche, i suoi rituali laici, le scoperte di cantanti nuovi (“e questo chiccazz’è?“) e la riscoperta di quelli antichi (“ma questo ancora campa?“).
Io lo seguo come fenomeno di costume, la gran parte delle canzoni me le dimentico un attimo dopo che le ho ascoltate. In questo ascolto distratto però mi è caduta l’attenzione sul testo di una canzone in particolare. Tra l’altro cantata da due interpreti che mi piacciono come la pizza con l’ananas, entrambi simpatici come la sabbia nelle lenzuola. Parlo di Fedez e Masini e la canzone in questione si intitola Il male necessario.
Parla di un figlio che diventa uomo e da uomo diventa padre, un percorso di crescita, doloroso, ma inevitabile. Il male necessario, appunto: quello di un figlio che deve quasi necessariamente deludere il padre che aveva aspettative su di lui, così da crescere in modo autonomo. E quello di un padre che deve accettare che il figlio tradisca le sue aspettative, se vuole farlo crescere per davvero.
“Ogni padre inizia come fosse un Dio, ma poi finisce che diventa un alibi”. E’ vero da padre, è vero da figlio. E ce ne vuole per capire che un padre non potrà mai essere un Dio, ma non dovrebbe neanche mai diventare un alibi. Facciamo il meglio che possiamo o almeno, quello che speriamo sia il meglio, ma senza libretto di istruzioni, né per i padri, né per i figli.
“So che in fondo non c’è tempo, quante cose che cambiano, ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai”. Quando scelsi Filosofia all’università mio padre mi disse che gli avevo dato la delusione più grande della sua vita. E forse fu proprio la rabbia che sentii a darmi la spinta per andare avanti e raggiungere quei traguardi che gli avrebbero dimostrato che si sbagliava. D’altra parte anche lui ci ha messo del tempo per non deludermi: c’è stato un momento in cui mi ero chiesto cosa avesse trovato mamma in lui. E ringrazio Dio di averci dato il tempo per conoscerci fino in fondo e superare le reciproche delusioni. Il male necessario.
“Se è vero che siamo solo di passaggio, il vero obiettivo non può essere la meta, ma imparare a godersi il viaggio. Quando crescerai e non mi chiederai nemmeno più il permesso, si impara vedrai che i mostri non stanno soltanto sotto al letto”. Sarò una delusione per i miei figli? Da una parte mi auguro di sì, almeno un po’. Gli servirebbe come sprone, com’è servito a me, per dare il meglio. Spero però che non prendano le mie debolezze ed i miei errori come alibi. D’altra parte, ormai li conoscono abbastanza per dire che loro non mi deluderanno mai, qualsiasi scelta faranno. E se pure ci sarà una punta di delusione, sarà appunto un male necessario, per volergli bene come sono e non come vorrei che fossero.
Insomma, a volte anche una canzone di San Remo ti aiuta a riflettere. Un momento doloroso ma bello. Un male necessario.